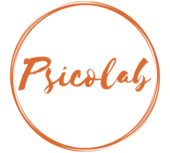Il cinema della Seconda Guerra Mondiale si avvia perciò ad un tramonto illuminato dagli ultimi, allucinati bagliori di cineasti spesso incompresi o isolati.[1] Quasi sempre questi film scatenano discussioni infinite, altre volte finiscono ingiustamente ignorati. Emblematico, in questo caso, un titolo sopra a tutti: Il grande uno rosso[2] di Sam Fuller. Un battaglione combatte violentemente tutte le battaglie in giro per il mondo (Sicilia, Africa, Belgio, Normandia, Cecoslovacchia), fino a sbarcare nel D-day e scoprire, successivamente, l’orrido spettacolo dei forni crematori. Questo film ha avuto una gestazione piuttosto complessa: molti furono i momenti in cui la produzione pareva sussultare, e il regista non ebbe carta bianca nella realizzazione. Le iniziali quattro ore di pellicola furono ridotte a due ed in seguito, vi fu una scarsa circolazione del prodotto. The red big one, tuttavia, è un film importante: non solo perché una parte della critica ha gridato al capolavoro (e vi fu anche chi gridò all’orrore), ma perché questa cronaca dei lunghi anni della Seconda guerra mondiale è il progetto più caro, da molti anni meditato dal regista.
La violenza, il tema che il regista ha sviluppato per tutta la vita, la condizione dell’uomo sottoposto alle leggi straordinarie della guerra, sono esaminate con grande lucidità. Fuller non usa la violenza per farne dello spettacolo. Nel suo film non si vede scorrere sangue. In compenso, la realtà è descritta non solo con impeccabile abilità tecnica ma con uno stile, forse anche con una morale che si vogliono asciutti e nitidi. Due sequenze aprono e concludono il film. Esse condensano il significato della riflessione che è alla base del film: un istante prima del termine di una guerra uccidere è non solo legittimo, ma doveroso. Un istante dopo, significa assassinare: la differenza, che la lingua inglese rende esattamente, tra “murder” e “kill”. E, come si dice nel film, “We can’t murder anybody. You don’t murder, you kill.” “It’s the same thing. You don’t murder animals, you kill.”
Il ritegno, il distacco con il quale l’autore ha saputo dissertare su questa violenza, trasformarla da dinamica esteriore e spettacolare a ragione di distruzione interna, morale, degli individui, è il motivo per il quale in molti hanno definito questo film un capolavoro. C’è chi invece pensa che il film non sfugga alla regola: il solo fatto di volersi immergere nel 1980, nell’atmosfera di quegli avvenimenti, nel piacere di filmare le divise dell’Afrika Korps, gli elmetti dei marines o il cigolio dei carri armati scovati fra i ferrivecchi del genere, denuncia ad ogni istante una sola cosa, appunto, “quel piacere”.
Andando oltre ai giudizi della critica, bisogna comunque ricordare che Il grande uno rosso è stato anche un punto di riferimento per pellicole realizzate all’alba del XX secolo. Spielberg nel 1998 gira Salvate il soldato Ryan, e alcune immagini del suo film devono molto a Fuller: le citazioni dirette dello sbarco in Normandia, l’intuizione della cecità di fronte a un nemico nascosto. Gli ormai famosissimi primi 25 minuti del film – lo sbarco dei Gi sulla spiaggia di Omaha Beach all’alba del 6 giugno 1944, con tutto l’orrore della carneficina e l’incredibile eroismo dei sopravvissuti – sono un impressionante pezzo di cinema, realizzati sulla scorta della sconvolgente documentazione raccolta nel suo libro da Stephen E. Ambrose.
Col sussurro disperato “L’orrore, l’orrore”, il colonnello Kurtz (Marlon Brando) chiudeva Apocalypse now. Vent’anni cinematografici dopo quelle stesse parole sembrano riecheggiare nella mente del Capitano John Miller (Tom Hanks), reso sordo dalle bombe, mentre osserva sconvolto le carni dilaniate dei suoi compatrioti sulla spiaggia di Omaha Beach.
Se in Schindler’s list Steven Spielberg poneva un dilemma morale di difficile soluzione (Chi salva la vita di un uomo salva il mondo intero?), Saving Private Ryan, provocatoriamente, ne pone uno altrettanto ambiguo. La vita di un semplice uomo è più importante di quella di otto soldati, anonimi come lui? Il soldato semplice Ryan non è un genio, non ha particolari peculiarità e un ragazzo come tanti altri che ha avuto la sventura di perdere i suoi tre fratelli lo stesso giorno. Questa sciagura è diventata, paradossalmente, la sua fortuna poiché il Capo di Stato Maggiore americano ha deciso che salvare la sua vita ha la massima priorità nella Normandia sconvolta dallo sbarco delle truppe alleate. Una pattuglia di otto uomini guidata dal capitano John Miller si mette alla ricerca del soldato nella terra ostile di Francia, ancora in mano ai soldati tedeschi. La pattuglia è incerta sul da farsi, tormentata dallo scopo della sua missione. Il misterioso capitano John Miller è abituato a pensare che per ogni uomo della sua squadra sacrificato in combattimento ce ne saranno almeno dieci che si salveranno. Ma adesso i conti non tornano. Per ogni soldato della propria pattuglia, vittima della guerra, ce ne sarà sempre e comunque uno solo salvato: il soldato semplice Ryan dell’Iowa.
Su questo dilemma etico, si intrecciano due film:
· Il film di guerra. Saving Private Ryan si riallaccia ai war movies anni ’50. Tom Hanks incarna il ruolo di eroe senza macchia nella migliore tradizione del cinema americano. Tuttavia, si differenzia dalle opere dei maestri citati per la rappresentazione realistica della guerra. Qui, infatti, http:\\/\\/psicolab.neta è in bianco e nero, nessun ascondimento, nessuna finzione scenica. La violenza è rappresentata in tutta la sua crudeltà e brutalità, a tratti insopportabile. Una violenza carnale ed indignata che si distanzia da quella lucida e geometrica del Kubrick di Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket. L’ormai celebre sbarco in Normandia è messo in scena con un uso del sonoro terrificante che da la sensazione a noi spettatori di essere immersi davvero nel delirante mattatoio di Omaha Beach.
· Il film politico. Saving Private Ryan è un manifesto politico il cui messaggio potrebbe lasciare perplessi i più smaliziati spettatori europei. L’opera infatti ha un valore morale e vuole riavvicinare gli americani ad una patria fondata su valori leali e sinceri. Dopo decenni di insofferenza e intolleranza verso l’esercito americano e le sue ingerenze in politica estera, questo film è un omaggio all’America paladina della libertà, il cui sacrificio nella Seconda guerra Mondiale è stato essenziale per il mondo intero. Il film trasuda patriottismo dalla prima all’ultima sequenza e non a caso si apre e si chiude sulla bandiera americana.
La compattezza della sceneggiatura, pur con qualche lunghezza, offre uno spettacolo avvincente dal punto di vista emotivo con alcune pagine di cinema eccezionali.
Sempre nel 1998, presentato come l’anti-Spielberg, La sottile linea rossa di Terrence Malick, incarna effettivamente un cinema molto lontano da quello del cineasta di Salvate il soldato Ryan. Il suo film infatti si pone come rielaborazione dell’esperienza di guerra in conflitto con il paradiso naturale nel quale la battaglia si svolge. Tratto da un romanzo di James Jones, e già girato nel 1964, il film ha il suo punto di forza nella caratterizzazione dei personaggi, e nelle loro piccole storie che si incrociano e si scontrano con la Storia.
Ambientato nel Pacifico meridionale, ci propone una delle battaglie chiave della Seconda Guerra Mondiale, che riuscì a cambiare le sorti del conflitto nel Pacifico, e che fece registrare un numero enorme di perdite.
La storia parla di un gruppo di soldati americani, la compagnia Charlie, che deve conquistare la collinetta sotto il controllo dei giapponesi, a cominciare dal loro sbarco nell’isola fino alla partenza dell’ultimo sopravvissuto. Ma in primo piano non è la guerra sotto il suo profilo prettamente “fisico”, ma soprattutto la sua componente psicologica, i pensieri e le paure di questi uomini che si trovano di fronte alla morte.
Nel film vengono analizzate le riflessioni degli uomini sulla guerra, sul proprio ruolo come cittadini americani, come difensori della patria, ma anche come uomini.
Scaturisce dal film un senso di stranezza. L’orrore e la brutalità degli avvenimenti bellici sono trattati con estrema liricità. Lo stesso contrasto che visivamente si pone tra l’immagine della conflagrazione e la meravigliosa quiete della natura incontaminata. Un paesaggio che viene violentato, ferito a morte dal demone della guerra. Che civiltà porta la guerra, quale progresso? Gli indigeni guardano con stupore e paura i soldati. “Tu sei esercito!” esclama una donna indigena. “Tu sei morto e porti la morte, sei distrutto e porti distruzione. Morti. Tutti morti. Non è rimasto nessuno. Non è rimasto niente.” L’andamento lento della pellicola gli conferisce un ritmo poetico fatto di pause, di a capo, di capoversi ed estenuanti momenti di intimità. È come se il fluire della narrazione restasse imprigionato dallo stesso fango che rallenta l’incedere dei soldati, bloccato a terra e rallentato dal fuoco nemico. In questa pellicola è la parola prendere il sopravvento, il dialogo interiore sostituirsi a quello fra gli esseri umani.
Non c’è posto a Guadalcanal per gli eroi di Salvate Il Soldato Ryan. I demoni, le paure che attanagliano ogni uomo nella sua intimità si materializzano nelle figure anonime e senza volto del nemico. Nessun soldato Ryan da trovare e riportare a casa sano e salvo, solo azioni di guerra, feriti e morti: tutto torna con estenuante e ripetitiva cadenza ritmica. Una lunga guerra di posizione, di attesa, di immobilità che libera il pensiero nell’irreale silenzio del conflitto. L’intenzione del regista è di andare al di là delle apparenze e del realismo, per cogliere l’esperienza dell’individuo nel dramma della guerra. Quello che il film propone è allora un racconto che, procedendo per analogie ed ellissi più che per una esplicita pista narrativa, abbandona la tradizionale idea di guerra “buona” (ovvero lo scontro esemplare tra i buoni, i rappresentanti dell’idea democratica, e i cattivi), per lasciare spazio ad una approfondita riflessione sulla guerra in se stessa, come tragica attività umana. Il film, in effetti, rappresenta una meditazione etica di ordine generale sul tema della guerra, che viene proposta sia mediante l’uso di uno stile da documentario antropologico-naturalistico (si vedano in questa direzione le molte riflessioni etico-religiose con voce fuori campo: “Da dove viene il male che ha inquinato il mondo?” – “Perché la Natura lotta contro se stessa?” – “Chi sono io?” – “E se fossimo tutti parte di una stessa anima?”), sia ricorrendo alla “frantumazione” del protagonista in un gruppo di personaggi che si dibattono tutti, seppure in modo diverso, per capire la morte, la vita che sfugge, la natura estranea in cui sono immersi e che al tempo stesso li stimola ad andare al fondo di se stessi; sia infine con l’adozione di una prospettiva quasi “antistorica”, che porta il regista a mostrare il dolore e il male della guerra in sé e per sé più che a rappresentare uno scontro tra due forze storico-sociali. Tale astoricità si coglie a partire dal fatto che il regista non recupera in alcun modo la tradizione cinematografica del genere, ricca di materiali sulla guerra nel Pacifico, i quali, pur mostrando già una visione realistica e poco tranquillizzante della guerra (torture e assalti proditori, le trappole nella giungla, le battaglie notturne, ecc.), per un verso restano ancorati ad una rappresentazione del nemico tutta di parte, che inchioda il soldato giapponese nello stereotipo dell’individuo infido, crudele, sadico, e per l’altro rimandano comunque al cinema d’azione eroico e “di genere”. Malick invece, presenta il nemico, come uomini sofferenti quanto gli americani, come una innumerevole quantità di vittime di assurde strategie militari (c’è persino chi pratica lo zen, il massimo del pacifismo e del rifiuto a lasciarsi coinvolgere nel tumulto della battaglia e nel dolore della sconfitta). Tutti dunque accomunati dal dramma di essere vittime di una immane ed assurda tragedia – la guerra – di cui resta ancora qualcosa, forse molto, da capire, se è vero che fra i tanti interrogativi senza risposta suggeriti nel film: “Perché gli individui tendono ad autodistruggersi?”