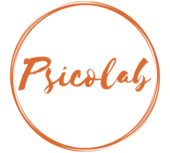I dizionari Italiani, gli organi d’informazione o i mass media utilizzano continuamente il termine conflitto sovrapponendolo semanticamente con ‘violenza’ e ‘guerra’.
Noi scontiamo ad oggi un deficit culturale e storico: la nostra è una cultura che tende a rappresentarsi come aconflittuale oppure, la tendenza comune è quella che ci porta ad estremizzare tra pace, quiete, armonia e guerra. L’affermarsi di una società fortemente individualistica, di un uomo senza legami, se non contrattuali, porta la persona ad identificarsi con un’immagine non definita dove solo i conflitti già conosciuti e disciplinati possono essere accolti ed elaborati.
Dobbiamo innanzi tutto fare chiarezza sul termine conflitto, legittimarlo, e distinguerlo chiaramente dal termine ‘violenza’. Esiste l’idea della necessità di negare, di tenersi lontani e protetti dai conflitti poiché si crede che questo possa generare in violenza. Differentemente la violenza appartiene alla sfera del danneggiamento, della distruzione, nel fare qualcosa d’irreversibile. Nella nostra cultura la parola conflitto evoca, comunque, immagini dolorose e sgradevoli, fa pensare allo scontro, al combattimento, al disagio, allo spreco di tempo e di energie nella lotta. Tuttavia l’esistenza di conflitti è intrinseca alla natura umana. Negare ciò significa rendere difficile il suo studio e relegare universalmente tutti i tipi di conflitti nel regno del patologico.
L’etimologia del termine conflitto deriva dal latino confligere che significa urtare, battere insieme. Nell’ esperienza comune, gli scontri e gli urti presuppongono l’esistenza di almeno due ‘cose’; per parlare di conflitto, dunque, si devono individuare almeno due entità che reagiscono tra loro. Di solito, quando nasce un conflitto tra due o più parti, l’unica sola preoccupazione è lottare per imporre la propria tesi.
“Secondo il filosofo Schopenhauer la slealtà è insita nella natura dell’uomo, per cui ognuno immancabilmente cerca di ottenere ragione sia con strategie corrette, sia, soprattutto, con mezzi illeciti. E’ raro che lo scopo di una discussione sia analizzare una questione con la ragione, esso è piuttosto l’avere ragione”1.
Per molti esiste una sovrapposizione tra conflitto e violenza che nasce da come esso viene rappresentato, basti pensare alla fiction televisiva o cinematografica, o addirittura ai cartoni animati per accorgerci che il conflitto ha una connotazione e un aspetto violento. Del resto, in genere, l’abitudine è quella di caricarsi di collera e di voler vincere a tutti i costi, ‘battendo l’avversario’. Tale credenza stereotipata è un luogo comune che va modificato poiché se il conflitto degenera in violenza non si può che evitarlo, ma evitarlo significa negarci la possibilità di migliorare le nostre competenze nella relazione interpersonale e sociale. La relazione, infatti, è carica di conflitti: una relazione che non consenta il conflitto diviene una relazione ‘cimiteriale’. La comunicazione non viene usata per giungere ad un accordo ma, piuttosto, per lanciarsi reciproche accuse, inutili ironie e beffe. Il conflitto tocca il suo culmine quando, più che verbalizzare, le parti agiscono e la violenza prende il sopravvento.
E’ bene intendersi: un conflitto non è un episodio isolato, ma un rapporto con una sua storia, un suo motivo, una sua dinamica, un suo contesto. Il problema principale è distinguere tra conflitto positivo e conflitto negativo. Il conflitto positivo può condurre ad una crescita e al superamento di ostacoli: al pluralismo e al decentramento cognitivo dei partecipanti. Il conflitto negativo invece può portare all’anarchismo globale, alla cessazione dei rapporti, a tutta una serie di blocchi emozionali. Ogni qual volta si verifica un litigio aumenta notevolmente l’intensità della comunicazione, l’emotività dei contendenti e l’orientamento di ognuno è polarizzato e separatista. Problemi organizzativi di ogni genere a lungo termine possono perciò essere considerati dei fattori stressogeni che necessitano di una adeguata attenzione, supervisione, e gestione.
Assume una valenza particolare legittimare il conflitto come un luogo d’esperienza dove possiamo attivare nuovi apprendimenti.
Dovremmo iniziare a ragionare riflettendo sulla natura della tendenza ad incolpare gli altri, essere più attivi che reattivi alle situazioni, incentivando analisi e responsabilità riguardo alle nostre emozioni per gestirle in modo migliore, riflettere sulla naturale tendenza ad incolpare gli altri, non ingaggiare ‘a priori’ delle vere e proprie battaglie, osservare di più il presente per comprendere le possibili conseguenze. Fare più chiarezza rispetto ai nostri bisogni personali, ai nostri desideri, alle nostre convinzioni e responsabilità, ci dà la possibilità di lavorare sull’entità del problema.
L’uomo di oggi è legato a quelle norme dello Stato secondo cui è considerato uguale e democratico, è un uomo senza conflitto che si trova lontano dalle modalità di trasmissione tradizionale legate alla concezione culturale di comunità, di scambio, di legame.
Tali modalità sono scomparse per la delocalizzazione e l’assenza di radici, ma questo comporta il vivere i propri conflitti come qualcosa di anormale, e genera un senso di inadeguatezza nel rapporto con sé stessi2. Abbandonare l’idea del conflitto come ‘problema’, significa vedere questa dinamica come ‘relazione’ di crescita e sviluppo.
Attuando una semplificazione potremo evidenziare aspetti conflittuali della relazione e dividere i conflitti in:
1.emotivi;
2.di dati;
3.di interessi;
4.strutturali e di valori
Conflitto emotivo3: controversie che hanno origine all’interno della relazione, in cui i sentimenti reciproci ne sono sovente la causa scatenante.
Il conflitto emotivo può essere illustrato come spontanea antipatia tra le persone coinvolte, e in genere risale ad eventi affettivo – emotivi tra persone che altrimenti non troverebbero difficoltà nella relazione.
Una situazione classica in cui si sviluppa il conflitto emotivo è quando si trascura l’opportunità di chiarire netti confini tra sé e gli altri. Comunemente quando siamo coinvolti in un conflitto, o in un potenziale conflitto, ci sentiamo come minacciati. In alcuni casi possiamo ritenere troppo pericoloso essere onesti, perché, temendo la collera dell’altra persona, il suo rifiuto o una ripercussione negativa, ci percepiamo troppo vulnerabili. A volte accuratamente evitiamo di esprimere i nostri sentimenti più profondi perché non vogliamo che gli altri si arrabbino con noi, o temiamo che ci rifiutino completamente. E’ sempre la paura che spinge alcune persone ad essere oltremodo rigide nelle proprie opinioni e nei propri valori, sovente con questo atteggiamento nascondono un senso di sé molto fragile: dal momento che temono di essere colti in errore o di essere visti in modo negativo, leggono qualsiasi sfida al loro sistema di valori come un attacco personale, una minaccia alla loro identità.
Il conflitto di dati4: si ha quando persone coinvolte in una controversia non condividono gli stessi elementi e possiedono informazioni parziali, o travisate.
Altrimenti definito anche come ‘fraintendimento’. Il motivo per il quale spesso accade di non comunicare con successo è dovuto al fatto che di solito siamo abituati a non dare il dovuto ascolto a ciò che ci viene detto, soprattutto quando chi dovrebbe ascoltare è impegnato nel far accettare le proprie opinioni. Possono esserci alcuni problemi nella comunicazione sia a livello di elementi comunicativi (codice linguistico, messaggio e canale) sia a livello di feed-back.
Le persone, nel comunicare, devono essere in grado di scambiarsi critiche costruttive anziché distruttive e atte solo a ledere o biasimare l’interlocutore. Il vero significato nell’atto comunicativo è dato da chi ascolta e non tanto da colui che emette il messaggio. Chi lancia il messaggio desidera trasmettere qualcosa sia relativamente all’ oggetto della comunicazione, sia relativamente a se stesso. E’ importante che chi trasmette abbia un impulso chiaro, desideri essere compreso e sappia quello che vuole dire all’altro. Per ricevere in modo ottimale la comunicazione è necessario che colui che ascolta, desideri apprendere correttamente quello che l’altro dice.
Il conflitto di dati, quando è puro, è la forma di conflitto più semplice da trattare, in quanto per la sua composizione basta ripercorrere la vicenda a ritroso, o descrivere l’oggetto di una discussione, rendendo comuni le informazioni e i dati posseduti dalle parti.
Il conflitto di interessi5, si riscontra quando le parti hanno interessi contrastanti che possono essere soddisfatti solo a danno dell’interesse dell’altro.
Si hanno conflitti di interesse quando:
a) le persone non sono state completamente oneste e aperte nelle proprie richieste o nell’esprimere i propri bisogni e uno dei due si è sentito raggirato o tradito nella sua buona fede. Non è necessaria una truffa in piena regola perché scoppi un conflitto di interessi, anche una mezza-verità, o una verità semi-nascosta può mettere in crisi una relazione di fiducia;
b) ci si trova di fronte a reiterata negligenza, promesse non mantenute,
responsabilità evitate, leggerezze, ritardi. Queste sono tutte potenziali
minacce per innescare un conflitto e incrinare una relazione di reciproca
affidabilità;
c) una o entrambe le parti hanno ‘intenzioni nascoste’.
Conflitto strutturale o di valori6: si tratta di un conflitto che non riguarda tanto le singole persone, ma il gruppo e l’organizzazione sociale cui le persone appartengono. Questo tipo di conflitto quindi non ha molto a che fare con la specifica situazione o con le singole persone coinvolte, ma piuttosto interessa un intero gruppo o organizzazione con la quale si condividono le stesse opinioni o valori.
Il conflitto, in genere, si presenta in maniera più articolata e complessa da essere difficilmente identificabile in un’unica e precisa categoria, e la sua descrizione può avvenire grazie ad una combinazione tra due o più generi tra quelli illustrati precedentemente.
E’ possibile distinguere 4 stili diversi di porsi di fronte ad un conflitto.
Attaccante – difensore
Remissivo
Sfuggente
Congelatore
L’Attacante-difensore7 si distingue perché sembra sempre alla ricerca di potenziali nemici da combattere, focalizza subito la sua attenzione sui motivi per cui gli altri sono in errore e sui vantaggi da ottenere in ogni situazione. Si tratta essenzialmente di una mentalità ‘da combattimento’, antitetica a negoziale aperta e collaborativa, è refrattaria ai discorsi sulla prevenzione della violenza. In genere l’attacante-difensore tende a prevaricare sugli altri per paura che questi finiscano con approfittare di quelle che ritiene essere le sue ‘debolezze’, e si presenta sempre eccessivamente sicuro di ciò che vuole e otterrà. Non c’è alcuna volontà di apprendimento e di crescita insita nel conflitto, e di conseguenza nessuna volontà di concedere agli altri bisogni e obiettivi conciliabili con i propri. Tende a confermare continuamente la propria opinione di partenza, cadendo vittima del circolo vizioso.
Il Remissivo8 sembra adottare, a prima vista un comportamento agli antipodi rispetto all’attaccante-difensore: invece di cogliere la più piccola provocazione come una dichiarazione di guerra, il remissivo farà di tutto per ‘mantenere la pace’. La loro motivazione è la paura e la convinzione di non avere potere. Negli scontri cedono subito dicendo a se stessi che dal momento che non potranno ottenere ciò che desiderano, è meglio arrendersi. Dato che detestano combattere, è meglio ‘porgere l’altra guancia’. Quella che segue è una categorizzazione adottata assai frequentemente nei corsi americani di formazione pratica per conciliatori, la cui paternità è di difficile individuazione. I remissivi si presentano altrettanto falsamente sicuri degli attaccanti-difensori: come quest’ ultimi sono incolleriti ed offesi, convinti di essere nel giusto e con nessuna responsabilità nel problema da affrontare.
Lo Sfuggente9 rappresenta l’estremizzazione del remissivo: non vuole nemmeno arrivare a riconoscere che esista un conflitto. Anch’egli si astiene dall’ammettere qualche sua responsabilità nel conflitto e lo fa a modo proprio cioè negandone l’esistenza. La negazione sembra essere un bisogno radicato e profondo negli sfuggenti, dal momento che essi fanno di tutto per evitare di confrontarsi con i proprie gli altrui problemi. Sembrano quasi paralizzati dalla paura, non hanno una grande autostima e pensano che non ci sia una via d’uscita.
Il Congelatore10 si presenta più preoccupato di mantenere intatta la “sanità” della propria posizione, che di fare qualcosa per risolvere il conflitto. Non sente l’impulso ad attaccare o sconfiggere l’altra persona, piuttosto la sua soddisfazione si autoalimenta nel restare trincerato nel proprio punto di vista. Sembra guidato dall’incontentabile bisogno di avere ragione e lo vuole provare chiudendo qualsiasi comunicazione con l’altro. Sembra strano, ma la causa principale d’ogni espressione violenta del conflitto è la paura, la quale si esprime sotto diverse forme.
Se pensiamo alle paure che posso scaturire dal conflitto relazionale potremmo riflettere rispetto a:
La paura della collera di un’altra persona è uno dei timori più diffusi. Dipende in genere dal fatto che si è cresciuti con persone autoritarie che hanno imposto sempre una propria posizione up su una down, la quale a mano a mano ha preso il sopravvento nei tratti di personalità di quel soggetto. Così facendo quegli atteggiamenti si sono ripetuti nei rapporti interpersonali sotto forma di modelli operativi interni11. Quando una persona tende a lasciarsi paralizzare dalle proprie paure, ovvero dalla collera degli altri, per prima cosa è necessario aiutarla ad acquisire maggiore consapevolezza della realtà della situazione e ad accettare che occorra rendere palese il proprio impulso emotivo, ma occorre anche chiarire che questo impulso, anche se palesato, non cambierà subito la situazione.
La paura di essere rifiutati, derisi o venire ostracizzati, invece, impedisce di assumersi rischi o di essere aperti e onesti nella propria carriera lavorativa, così come nelle relazioni interpersonali. Anch’essa, come schema comportamentale, richiede molto tempo per essere modificato. Occorre che la persona cominci ad osservare se stessa con onestà e sincerità, chi è, che posizione occupa e che cosa pensa, sente, agisce12.
La paura di ascoltare può portare la persona a discutere per anni senza mai affrontare il conflitto vero e proprio. Ciò implica la ricerca di un buon alibi che permette di evitare l’accettazione di se stessi e, conseguentemente degli altri. Il nervosismo dell’uno viene così trasmesso all’altro, volendo entrambi affermare la veridicità delle proprie ragioni, ma, dal momento che non si intende affrontare veramente il conflitto, ci si rifiuta di ascoltare l’altro e quindi di capire. Di solito la prima persona che non si vuole ascoltare è se stessi. Diventa in questi casi essenziale ascoltarci, lasciando che l’altro, facendoci da specchio, ci restituisca quegli aspetti di noi stessi che non volevamo accettare perché troppo dolorosi e che, quindi, abbiamo finito per proiettare al di fuori di noi, nell’altro.
Chi evita di affrontare il conflitto, chi ne ha paura, in genere teme di riconoscere se stesso e mettersi in discussione. La maggior parte di noi è a disagio quando deve affrontare un conflitto e, a meno che la situazione non diventi davvero dolorosa e insopportabile, si finisce con l’abituarsi allo status quo. Difatti, in genere non piace il cambiamento ed è apparentemente più facile accettare ciò che si conosce (principio di omologazione) piuttosto che affrontare ciò di cui si è ignari e che per lo più è diverso da noi (principio di differenziazione).
La modalità con la quale la persona può reagire di fronte ad una realtà conflittuale è diversificata e dipende da molti fattori tra i quali la ‘storia’ del soggetto, la realtà culturale, sociale alla quale appartiene, le proprie modalità di interazione.
Vi possono essere alcuni aspetti in comunione tra cui:
1) Tutti i conflitti sono impostati in modo che debba esserci una parte vincente, la propria, e una perdente, il proprio antagonista (nella maggior parte dei casi si verifica, invece, che con tale atteggiamento si esce da un conflitto comunque perdenti).
2) Gli attori del conflitto tendono a trincerarsi nella propria posizione.
3) I bisogni e le richieste dell’altro non vengono prese in considerazione
4) Ci si adopera tutti con molta energia a non affrontare il conflitto direttamente e giocando tutte le carte per evitarlo.
5) L’autocritica è assente. E’ il nemico ad essere in errore13.
È possibile pensare al conflitto, non più come esperienza negativa, ma come parte integrante e inevitabile della nostra vita. Esso ci dà la possibilità di abbattere la nostra resistenza al cambiamento, permettendoci, una volta superata la crisi, di crescere. A questo punto diventa necessaria la mediazione del conflitto e la sua gestione, altrimenti la crescita e lo sviluppo insito in esso potrebbero non essere raggiunti. La mediazione non è una pratica nuova ma è stata trasmessa alla nostra società patriarcale attraverso la tradizione greco-romana e poi quella medievale che recupera molto dall’Oriente Asiatico, mondo fin dall’antichità attento alle dissonanze o piuttosto alla ricerca dell’armonia come culto tra due polarità non antitetiche14.
Sempre di più ai nostri giorni c’è la consapevolezza che la parola,il dialogo, la relazione sono importanti per la costruzione di significato, per la crescita della persona in ogni sua sfera.
Conversazione e dialogo non sono semplicemente degli strumenti o mezzi attraverso cui operare nella situazione, ma sono anche aspetti da coltivare nella vita a livello sociale, poiché riguardano ogni aspetto dell’esistenza dell’individuo.
Noi ci concentriamo sul pensiero di cinque persone in particolare:
1.Paulo Freire (1921-1997), pedagogista brasiliano, il concetto di dialogo viene analizzato come prima forma di educazione. Secondo il pedagogista “alfabetizzazione, coscientizzazione, liberazione”, sono le tappe della pedagogia sociale, che costituiscono l’ossatura portante della sua opera: <<La pedagogia degli oppressi15>>. Educare significa anche comunicare creando le premesse della collaborazione. Questa concezione di educazione è diametralmente opposta a quella ‘depositaria’, la quale, negando il dialogo e basandosi su postulati che richiamano un tipo di rapporto ‘verticale’ minimizza il potere creatore degli educandi e soddisfa gli interessi degli oppressori.
2.Hans Georg Gadamer Hans-Georg Gadamer16 (1902-2002), filosofo ermeneutica del Novecento, utilizza la metafora della conversazione per pensare a come si può comprendere ciò che abbiamo di fronte, l’orizzonte che ci si prospetta davanti. La comunicazione, il dialogo presuppone un linguaggio comune ed è una modalità attraverso cui si giunge ad un accordo (talvolta chiamato struttura dialogica di comprensione).Egli descrive la conversazione come un processo di comprensione reciproca tra due persone. Ogni conversazione si potrà aprire all’altra persona se veramente è accettato il suo punto di vista peculiare come degno di considerazione. Ciò che deve essere colto è l’obiettivo, in modo che le persone possano concordare con l’altro su un argomento.
3.Jürgen Habermas17 Jürgen Habermas distingue radicalmente tra agire strumentale e agire comunicativo, sottolineando come l’agire strumentale sia basato su un sapere empirico, organizzato secondo regole tecniche e realizzato nel lavoro, e l’agire comunicativo consista in un’interazione fra individui mediata simbolicamente, cioè tramite il linguaggio e organizzata sulla base di norme che definiscono aspettative reciproche di comportamento; presupposti della teoria dell’agire comunicativo cominciano ad essere posti da Habermas in diversi testi degli anni ’70, in particolare nella Teoria della verità. Qui egli precisa cosa si può intendere per situazione discorsiva ideale. Essa è caratterizzata dall’esclusione di qualsiasi distorsione dai contenuti della comunicazione. Tutti i partecipanti non nutrono altro intento se non quello di offrire il loro contributo ad una ricerca comune attraverso argomentazioni critiche in loro possesso che vengono offerte ai partecipanti.
4.,David Bohm(1917-1992), eminente fisico, propose concrete risposte riguardo alla concezione di dialogo, in particolar modo a coloro che, come Peter Senge18, si occupano di sviluppo organizzativo. Il significato è per Bohm un fenomeno sociale, prodotto non solo da singoli individui, ma da gruppi, comunità, società e culture che mantengono, attraverso la lingua e intese concordate, la conoscenza. Il pensiero non è il risultato di un individuo isolato, ma è per lo più un fenomeno collettivo. Nel dialogo, un gruppo esplora complesse questioni da molti punti di vista.
5.Martin Buber19 (1978-1965) filosofo ebreo, ha reso un contributo significativo per la valutazione dell’incontro nel dialogo: per quanto si possa fare a meno del linguaggio e della comunicazione, una cosa che sembra appartenere indispensabilmente alla caratteristiche del dialogo è la reciprocità dell’azione interiore. I risultati del dialogo sono il rispetto e la comprensione delle diverse opinioni. Se più persone comunicassero dialogicamente ci sarebbe più rispetto per le diverse opinioni. Con la comprensione non avrebbero più modo di esistere tanti conflitti.
Il conflitto è spesso alimentato da pregiudizi e stereotipi che irrigidiscono le persone nelle rispettive posizioni, ad esempio gli errori logici di comunicazione o le discrepanze comunicative.
Errori logici
visione a tunnel: il partecipante coglie solo gli elementi della discussione che appartengono al suo punto di vista;
generalizzazione: il partecipante effettua generalizzazioni su parti di un tutto, su fenomeni parziali o irrilevanti;
ragionamento dicotomico: il partecipante vede la realtà o bianca o nera, e non si mostra capace di alcuna mediazione;
esasperazione: lo stile comunicativo del partecipante tende al perfezionismo, al rigido dogmatismo ed alla ricerca della risposta
Discrepanze comunicative:
cognitiva: è provocata da mancanza di informazioni o da difformità di conoscenza tra i vari interlocutori;
nei fini: quando i partecipanti alla discussione hanno obiettivi e fini diversi;
nelle attribuzioni: un partecipante dà delle spiegazioni che l’altro non condivide;
strumentale: quando si cerca di imporre comportamenti che l’altro partecipante non è disposto ad accettare;
culturale: differenze di schemi, di gusti, di ideologie
Diviene fondamentale affermare la natura negoziale della comunicazione, fondata sul riconoscimento dell’altro e delle sue ragioni, sull’interdipendenza tra i soggetti, infine sulla consapevolezza che la capacità dei riceventi di leggere, interpretare, e utilizzare i contenuti della comunicazione. Quest’ultima deve essere adattiva, contestualizzata e situata20. Comunicare, infatti, non significa semplicemente informare, ma anche e soprattutto “entrare in relazione” con soggetti esterni a noi. Un buon comunicatore ha tra i suoi aspetti peculiari la capacità di stare in ascolto dell’altro, la comprensione e l’analisi del contesto entro cui avviene la comunicazione e sicuramente dovrà negoziare la propria modalità comunicativa rispetto alla persona con cui interagisce E’ importante diventare consapevoli della nostra comunicazione, degli effetti che essa ha su di noi, sui nostri interlocutori e sulle nostre relazioni per trasformarla in comunicazione efficace. Affinché le parole diano sollievo e creino benessere, in noi stessi e negli altri, aiutandoci a ridurre lo stress, gli errori e le incomprensioni; è indispensabile acquisire consapevolezza di che cosa diciamo, di come parliamo, degli stati emozionali nostri e di coloro con cui stiamo interagendo, sia di persona che al telefono o attraverso una comunicazione scritta.
La consapevolezza è alla base dell’empatia: quanto più aperti siamo verso le nostre emozioni, tanto più abili saremo anche nel leggere i sentimenti altrui. Questa capacità che ci consente di sapere come si sente un altro essere umano entra in gioco in continuazione, sia in ambito privato (nelle relazioni sentimentali, con i figli o con gli amici) che in ambito professionale (si pensi alla giornata lavorativa di un venditore o di un dirigente).
Ogni comunicazione ha un aspetto di relazione e di contenuto: la prima riguarda gli atteggiamenti che definiscono il rapporto tra le persone, mentre la seconda è il fine esplicito per cui le persone comunicano. Nella società d’oggi non è facile rilevare negli ambienti lavorativi la consapevolezza, se non la messa in atto della buona relazionalità che tanto apporterebbe alle modalità lavorative, alla struttura organizzativa e alle persone che la compongono con il loro bagaglio emotivo ed esperenziale; anche nella letteratura contemporanea troviamo degli accenni ad esempio nel libro Il barone rampante, di Italo Calvino21 vengono descritte molto bene le tante situazioni nelle quali vi sono parecchi bisogni umani che non possono essere soddisfatti ricorrendo alla categoria dei diritti, sia pure di cittadinanza. Sono questi i bisogni di relazionalità, che sempre più si avvertono non solamente in ambito familiare e nel territorio, ma soprattutto nei luoghi di lavoro è percepito come necessario il bisogno di costruire sistemi di relazioni tra soggetti diversi ed eterogenei. “Capì questo – si legge nel romanzo -: che le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto, di vedere quante gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone – mentre vivendo per proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere l’altra faccia della gente, quella per cui bisogna tener sempre la mano alla guardia della spada”22. Il Barone rampante aveva ben compreso che le persone, la società, le nostre organizzazioni, oggi più che mai in passato, hanno bisogno di soggetti che pongano alla base del proprio agire l’impegno al valore, cui subordinare gli strumenti del denaro e del potere.
Comunicare significa ‘condividere’, ‘mettere in comunione’, e per arrivare a tale modalità è auspicabile l’accrescimento del quoziente emotivo. Sviluppare il quoziente emotivo e parlare d’assertività significa migliorare la capacità di esprimere i propri sentimenti; scegliere come comportarsi in un dato contesto; difendere i propri diritti quando necessario; aumentare la propria autostima; sviluppare una sana dose di sicurezza in sè; esprimere serenamente un’opinione di disaccordo quando si ritiene opportuno; portare avanti i propri obiettivi che richiedono una modifica dei propri comportamenti; chiedere agli altri di rivedere i loro comportamenti quando vengono percepiti come fuori luogo o offensivi. Il comportamento assertivo è quel comportamento attraverso il quale si affermano i propri punti di vista, senza prevaricare né essere prevaricati. Si esprime attraverso la capacità di utilizzare in ogni contesto relazionale la modalità di comunicazione più adeguata. L’assertività è un modo di comunicare che nasce dall’armonia tra abilità sociali, emozioni e razionalità senza necessariamente modificare la propria personalità. È una tecnica che può essere appresa e, con la pratica, può essere anche migliorata23. Nelle organizzazioni, nelle professionalità, nel lavoro si richiede all’individuo conoscenza, competenza, flessibilità, capacità d’adattamento al cambiamento, quoziente emotivo ed intellettivo; tutto ciò implica necessariamente, nella riduzione di tempi d’azione e nella globalizzazione, lo sviluppo della creatività nel posto di lavoro. Il futuro di un’azienda dipenderà dall’efficacia con cui essa acquisisce un’informazione, l’interpreta e agisce di conseguenza. Poiché la creatività attinge contemporaneamente dalle azioni e dai valori di una persona, consci ed inconsci, in modo analitico e intuitivo, un ambiente di lavoro creativo necessita davvero dell’entusiasmo e dell’impegno di tutto l’individuo24.
Si può affermare che l’unica cosa certa per la persona, per l’organizzazione, e per la società è il cambiamento. Diviene importante riuscire a rintracciare una ‘economia’ dei conflitti all’interno dell’organizzazione per farne momenti di incentivo e crescita. I Conflitti Organizzativi si possono rilevare come riferiti al comportamento delle singole persone facenti parte dell’organizzazione (primo livello), oppure a quello di interi gruppi individuabili di persone riuniti da strutture, procedure o professionalità comuni (secondo livello), ed infine al comportamento direzionale che viene associato alla definizione delle strategie, degli obiettivi e dei valori dell’Organizzazione nel suo complesso (terzo livello). Come accennavamo esistono tre tipologie di conflitto nelle organizzazioni: intrapersonale (primo livello), intragruppo (secondo livello), intergruppo (terzo livello).
Il conflitto intrapersonale è individuale e può apparire in occasione della non corrispondenza tra le competenze attese, compiti assegnati dall’organizzazione, con le competenze individuali intese come insieme d’interessi, valori, capacità. Tale conflittualità può generarsi grazie all’incompatibilità tra persona la persona e il compito assegnatole, l’incompatibilità tra bisogni dell’individuo e obiettivi organizzativi, richieste eccessive da parte dell’organizzazione rispetto alle reali capacità o possibilità nel momento del soggetto. In un’organizzazione con un forte conflitto intrapersonale possono scatenarsi alcune conseguenze tangibili come l’aumento del turnover, la malattia, l’assenteismo o disturbi psicosomatici.
Il conflitto intragruppo è una forma di conflitto tra i membri di uno stesso gruppo di lavoro. I fattori che lo causano sono legati allo stile di leadership autoritario, alla struttura del compito complessa, alle grandi dimensioni dei gruppi (creazione di sottogruppi con finalità contrastanti), alla composizione eterogenea dei gruppi negli atteggiamenti, valori, interessi, stili interpersonali ed ai risultati negativi in ambienti ad elevata competitività interna.
Il conflitto intergruppo emerge tra gruppi di lavoro diversi ad esempio tra squadre, tra reparti, tra funzioni, di una stessa organizzazione. Le variabili che possono provocarlo riguardano principalmente la forte differenziazione tra sottosistemi di un’organizzazione, l’elevata interdipendenza tra reparti/funzioni, le risorse limitate che l’organizzazione detiene. I soggetti in questa situazione sono portati ad identificarsi con il gruppo al quale appartengono per valori, obiettivi e modi di percepire la realtà; il conflitto può verificarsi nel caso in cui uno o più gruppi provino frustrazione dovuta al protratto mancato raggiungimento dei propri obiettivi per cause attribuite – anche parzialmente – all’altro gruppo in conflitto. Tali dinamiche implicano che un gruppo percepisca un altro gruppo come ostacolo diretto nel raggiungimento dei propri obiettivi ed è per questo che non si può parlare di competizione che presuppone il dividersi un premio comune. In altre parole potremo dire che un conflitto può nascere da fraintendimenti, differenti opinioni, diversità di valori, differenza di interessi, differenze di carattere e personalità, sovrapposizione delle differenze, stress e ansia, aspettative disattese o possono essere generati da un cattivo uso del potere detenuto non necessariamente a livello verticale, ma altresì a livello orizzontale. Il conflitto organizzativo può divenire un momento di grande apprendimento; in ogni organizzazione, costruita intorno a persone che si relazionano nel quotidiano, sono presenti conflitti. Il conflitto è un processo relazionale, è dinamico, non un prodotto assoluto. Schein 25 che definisce l’organizzazione come un sistema aperto la vede in costante interazione con l’ambiente. L’organizzazione ha molteplici scopi e funzioni che a loro volta interagiscono con l’ambiente circostante. Diventa importante pertanto fare attenzione agli insiemi di sistemi e sottosistemi (ruoli, gruppi,…) che la compongono. L’ambiente pone esigenze e limitazioni di vario tipo e in varie forme; il funzionamento totale dell’organizzazione non può quindi prescindere dal valutarle. Il conflitto organizzativo, a qualsiasi livello si verifichi è sempre però la spia di una disfunzione esistente nel Sistema organizzativo E’ possibile arricchire la rete concettuale aggiungendo altre ottiche diverse, che come al solito in un approccio sistemico si intrecciano e si influenzano. Possiamo indicare Conflitti Organizzativi di natura: relazionale, organizzativa (strutturale o procedurale), economica (risorse a disposizione del sistema in relazione all’esterno), sociale. Tale qualificazione di conflitti può naturalmente essere presente in tutti i tre livelli sopra identificati. Le cause del conflitto intrapersonale come ci suggerisce Majer26 sono prevalentemente di tipo strutturale come incompatibilità persona/compito,incompatibilità tra bisogni della persona e obiettivi organizzativi e richieste eccessive da parte dell’organizzazione rispetto alle reali capacità della persona. I fattori che portano al conflitto intragruppo sono legati a stile di leadership autoritario, struttura del compito complessa, grandi dimensioni dei gruppi di lavoro, composizione eterogenea dei gruppi negli atteggiamenti, valori, interessi, stili interpersonali e risultati negativi in ambienti ad elevata competitività interna. In fine i fattori che causano conflitto intergruppi dipendono molto da forte differenziazione tra sottosistemi di un’organizzazione, elevata interdipendenza tra reparti/funzioni e risorse limitate.
Poiché le organizzazioni sono (anche) un carico di lavoro mentale, una richiesta di esibire comportamenti adeguati alla situazione, è necessario guardare le organizzazioni come una rete di processi relazionali, condotti da individui e gruppi, che condividono regole che disciplinano le dinamiche di relazione tra gruppi e soggetti27. “Le persone controllano, sospendono, raggruppano e trasformano le proprie percezioni degli eventi alla luce delle interazioni che essi hanno con gli altri nell’ambiente” 28.
Nelle concezioni più attuali troviamo centrali concetti come la riflessività dell’organizzazione introdotta da Schon e ripresa nella letteratura attuale da Andrea Vitullo, manager del marketing e nella comunicazione in aziende multinazionali, che in leadership riflessive, si chiede se il benessere organizzativo possa prescindere da quello personale; nelle organizzazioni la persona oggi non è solo risorsa necessaria ma inevitabile per le organizzazioni che cercano di dare un senso al proprio fare. “Solo comunicando con le persone che incontro nella mia vita riesco a realizzarmi come IO. Solo nel reciproco riconoscimento siamo entrambi finalmente noi stessi. Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere”29.
Trovare la strada giusta in un epoca di grandi cambiamenti non è facile. Oggi la sfida delle organizzazioni a livello mondiale è passare da un modello competitivo ad uno collaborativo, il che significa migliore comunicazione e rapporto tra gli individui. Internet, la Rete ha giocato un ruolo rilevante, poiché mezzo di costruzione, di scambio di conoscenze. In Wikinomics30, libro scritto da Anthony D.Williams, l’autore sfrutta la metafora dell’enciclopedia online Wikipedia per addentrarsi nell’analisi di un nuovo modo di concepire l’economia denominata infatti come il titolo stesso. Williams, definisce la nostra come l’era della scienza collaborativa’ esaltando la messa in condivisione delle conoscenze e l’emergere delle best practice (migliori pratiche) in uno scambio continuo tra gli individui, ipotizzando addirittura una ‘wikimpresa’. Le organizzazioni sono sistemi sociali aperti che generano senso nella relazionalità che si viene a costruire nei propri sistemi e sottosistemi.
NOTE
1. E. ARIELLI E G. SCOTTO, Conflitti e mediazione Introduzione a una teoria generale, Mondadori Bruno, Milano 2003, cit., p.105.
2. Cfr. M. BENASAYANG E A. DEL REY, Elogio del conflitto, Feltrinelli, Milano 2007.
3. Cfr. E. ARIELLI E G. SCOTTO, Conflitti e mediazione. Introduzione a una teoria generale, Mondadori, Milano 2003.
4. Cfr.Ibidem
5. Cfr.Ibidem
6. Cfr.Ibidem
7. Cfr.Ibidem
8. Cfr.Ibidem
9. Cfr.Ibidem
10. Cfr.Ibidem
11. Cfr. J. BOWLBY, Attaccamento e perdita, Vol. 2: La separazione dalla madre, Boringhieri, Torino 1978.
12. Cfr. J. BOWLBY, Costruzione e rottura dei legami affettivi, Raffaello Cortina Editore, Milano 1982.
13. Cfr. E. ARIELLI E G. SCOTTO, Conflitti e mediazione. Introduzione a una teoria generale, Mondadori, Milano 2003.
14. Cfr. M. MARTELLO, Oltre il conflitto, dalla mediazione alla relazione; costruttiva, Psicologia McGraw – Hill, Milano 2003.
15. P. FREIRE, La pedagogia degli oppressi, A. Mondadori, Milano 1971.
16. Cfr. ibidem
17. Cfr. ibidem
18. Cfr. P. SENGE, La quinta disciplina, Sperling & Kupfer Editori (Edizione originale del 1990).
19. Cfr. M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo Editore, Milano 1993.
20. Cfr. E. CHELI, La comunicazione come antidoto ai conflitti, Punto di Fuga Editori, Cagliari 2003.
21. Cfr. I. CALVINO, Il barone rampante, Mondadori, Milano 1993.
22. Ibidem, p.129.
23. Cfr. N. NANETTI, Assertività, Manuale di formazione integrata alla comunicazione efficace, Pedragon, Bologna 2005.
24. Cfr. D. GOLEMAN, M. RAY E P. KAUFMAN, Lo spirito creativo, Bur, Milano 2005.
25. Cfr. E.SCHEIN, Cultura d’azienda e leadership, Guerrini e Associati, Milano 1985.
26. Cfr. V. MAJER, Il conflitto: teorie e modelli, In Rahim, M.A., ROCI. Rahim Organizational Conflict Inventory, Manuale Organizzazioni Speciali, Firenze 1995.
27. Cfr. M. DEPOLO, (a cura di), L’ingresso nel mondo del lavoro: I comportamenti di individui e organizzazioni, Carocci Editore, Roma 1998.
28. B. SCHNEIDER & A. E. REICHERS, “On the etiology of climates. Personnel Psychology”, 1983, pp.30- 36(1).
29. A. VITULLO, Leadership riflessive, la ricerca dell’anima nelle organizzazioni, Apogeo, Milano 2007, cit., p.47.
30. Cfr. D. TAPSCOTT, E A. D WILLIAMS, Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il mondo, Rizzoli, Milano 2007.